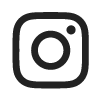Stanley Kubrick diresse “SHINING” (1980) dopo la grande delusione per come venne accolto il suo “BARRY LYNDON”(1975).
Scelse di avventurarsi in un genere cinematografico più popolare, il genere horror, ma rispettando la propria poetica ed elevandolo a capolavoro.
La storia è liberamente tratta da un romanzo di Stephen King e racconta di una famiglia che vive isolata nella stagione invernale presso un grande hotel disperso tra le Montagne Rocciose.
Presenze minacciose iniziano presto a tormentare il piccolo Danny, che ha il dono della luccicanza (lo shining del titolo) che gli permette di vedere e sentire cose che fanno parte del passato e del futuro.
Ma le forze malvagie che si muovono tra le mura dell’ Overlook Hotel esercitano una fascinazione pericolosa sulla mente di Jack Torrance, che matura l’idea di voler uccidere la moglie Wendy e il piccolo Danny.

Non sono poche le differenze tra la materia scritta da King e quella filmica di Stanley Kubrick e in un certo senso potremmo considerarle due opere davvero distanti.
Non a caso lo stesso Stephen King ebbe non poche perplessità alla visione del film e, amareggiato per come era stata stravolta la sua creatura, si scostò dal progetto.
Tuttavia, per quanto il romanzo di King sia uno dei suoi più belli, lo SHINING di Kubrick resta un film di una potenza visiva ed emozionale che trascende genere e libro e si eleva a opera filmica superba.
Basterebbe quella meravigliosa apertura a volo di gabbiano sulle Montagne Rocciose per comprenderne la maestosità e le intenzioni del regista che sì, era intenzionato a cimentarsi col genere horror, ma anche a guardare tutto col suo personalissimo sguardo e a concentrarsi sulla composizione del suo incubo a occhi aperti.
L’intreccio del racconto è disseminato fin dal principio di elementi e indizi che ci dovrebbero far presagire il peggio: dal dialogo nello stretto abitacolo dell’auto in cui si fa cenno a un fatto di cronaca nera in cui alcune persone dovettero cadere nelle pratiche del cannibalismo per sopravvivere; al colloquio di lavoro in cui Jack Torrence scopre che il precedente custode impazzì e fece a pezzi la sua famiglia con un’ascia; fino alle spaventose (pre)visioni del piccolo Danny.

La struttura di SHINING, più volta a turbare e inquietare lo spettatore, è ben esemplificata dal senso di straniamento che colpisce nelle lunghe sequenze che vedono il piccolo Danny correre nel labirinto di siepi o sul suo triciclo tra i corridoi dell’Overlook Hotel.
Sebbene Kubrick non sia stato il primo a utilizzare la steadicam (essa venne utilizzata anche da Carpenter nel suo HALLOWEEN nel 1978), egli fu il primo a saperne sfruttare al meglio le potenzialità e a oggi il suo lavoro è considerato forse il migliore in assoluto nella storia del Cinema, imitato da tanti, ma quasi irraggiungibile.
Kubrick arriva al cuore del genere horror, ma allo stesso tempo se ne allontana, costruendo un film sospeso tra realtà e incubo in cui molte delle cose che vediamo, sopratutto quando questi due piani vengono a intersecarsi tra loro, non vengono spiegate.
L’hotel e il labirinto e i fatti narrati diventano riflesso del nostro subconscio, una finestra sulle perversioni dell’animo umano, un’operazione a cranio aperto per scoprire come la mente funzioni se stimolata in certi punti.
Ma se la composizione è perfetta, dall’uso della luce al montaggio vertiginoso e fluido supportato da una colonna sonora sinistra e corposa, altro grande pregio del regista è la capacità di sfruttare al meglio le prove recitative dei suoi attori.
Il piccolo Danny Llyod è stato scelto tra circa 5000 ragazzini.
Shelley Duvall, conosciuta più per aver preso parte a film leggeri, arrivò pure ad ammalarsi sul set tanto è stato lo stress emotivo e fisico (Kubrick è sempre stato un perfezionista e pare abbia girato molte scene a orari improponibili).

Ma è la performance di Jack Nicholson a restare negli occhi e nella mente. Raramente un attore è stato capace di immergersi così totalmente in un ruolo. A oggi è considerata non a caso una delle sue interpretazioni migliori.
Il suo Jack Torrance è uno dei “mostri” più inquietanti mai apparsi sul grande schermo ed è sorprendente come Nicholson abbia lavorato sul suo personaggio che risulta essere spaventoso anche quando non dovrebbe esserlo. Lo avvertiamo come una minaccia fin dalle prime inquadrature, ne restiamo turbati quando inizia a mostrare i primi sintomi della follia omicida, ma siamo del tutto impreparati a vederlo buttare giù una porta a colpi di accetta con l’intenzione di far a pezzi la moglie e poi il suo bambino.
SHINING è considerato a ragione uno dei capolavori del genere horror, ma come abbiamo detto sarebbe anche riduttivo e in un certo senso fuorviante catalogarlo solo come tale.
Il pubblico moderno, assuefatto da tanti film tutti uguali (carichi di furbi jump scare) che devono necessariamente spiegare ogni cosa, potrebbe non coglierne la maestosità o interpretarlo addirittura come qualcosa di incompleto e mal scritto.
Ma il potere di SHINING sta proprio nella capacità di andare oltre le immagini. Sublime e perfetto nella sua architettura, esso è capace di colpirci anche violentemente, di disturbare il nostro guardare passivamente quanto accade sul grande schermo; di farci sentire improvvisamente scomodi su di quella poltrona che credevamo essere confortante fino a pochi minuti prima.
SHINING (e il cinema di Kubrick in generale) ci obbliga a ragionare, a porci domande, a ricercare delle spiegazioni non nel film, ma in noi stessi, in chi ci siede accanto.
Questo dialogo silente tra noi e la materia filmica, una volta accese le luci, spezzato quel sinistro sortilegio, diventa un interrogatorio che rivolgiamo a noi soltanto e che ci spinge a ricercare i mostri sotto al letto e quelli che si celano dietro un accomodante sorriso.
[rwp-review id=”0″]