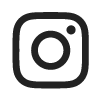“Credetemi, è tutto vero!“
Furono queste le poche parole che Lee Miller spedì nell’aprile del 1945 insieme alla busta che conteneva i rullini da inviare a Vogue America. Quelle fotografie, oggi raccolte in uno sterminato archivio che porta il suo nome, hanno rivelato al mondo, per la prima volta, tutto l’orrore nascosto nei campi di concentramento di Buchenwald e Dachau.
Elizabeth “Lee” Miller fu la prima fotoreporter a varcare la soglia dei lager quando l’esercito della liberazione ne forzò i cancelli a guerra conclusa. Ciò che vide fu immortalato in scatti che oggi restituiscono il racconto surrealista di un’aberrante fabbrica della morte, e infonde in chi li guarda nient’altro che il significato più fulgido dell’umana pietà.
Nei mesi precedenti Lee Miller, musa di Picasso, ex fotomodella che a Parigi diventò allieva e amante di Man Ray, aveva raccontato per il mensile più glamour d’America la guerra vista attraverso i suoi occhi, con un filtro inedito, onirico che prediligeva i particolari piuttosto che le visioni d’insieme. Famoso è il suo scatto che ritrae Regina Lisso, la figlia di un generale tedesco accasciata sul divano, senza vita dopo aver preferito il veleno alla cattura degli alleati. Una moderna Ophelia abbandonata alla morte, senza più difese.

www.leemiller.co.uk
I “prigionieri morti” di Lee Miller
L’occhio di Lee Miller si insinuò nei campi di concentramento con un approccio sfacciato, tra pile di cadaveri ammassati e resti umani ammucchiati come legna da ardere. Ai corpi senza vita che le SS non avevano fatto in tempo ad occultare (si presume per mancanza di combustibile) si frapponevano i corpi senz’anima: quelli dei prigionieri divorati dall’inedia, con il solo cuore pulsante a garantire il contatto con l’esistenza.
Scarnificati, oltraggiati, privati della dignità, resi irriconoscibili nelle fattezze, diseducati a reagire e perfino a pensare, poiché i pensieri erano stati sostituiti con il dovere dell’obbiedienza e il baratto della morte. Lee li aveva chiamati i “dead prisoners“, prigionieri morti.
Lee Miller diventò sempre più determinata a smascherare i corresponsabili di questa abominevole insensatezza: il popolo tedesco, che assisteva alla fine del nazismo con la pancia piena e le guance rubiconde, e che fino a poche ore prima aveva finto di non notare l’orrore e tragedia che si consumava a pochi km da casa. Un popolo che Lee non esitò a definire “schizofrenico” e invitò, insieme a decine di soldati, a visitare quei luoghi dove si era perso per sempre il senso del futuro.

© Lee Miller Archives. All Rights Reserved.
www.leemiller.co.uk
Il bagno nella vasca di Hitler
Quasi per uno scherzo del destino, l’esercito assegnò a Lee Miller e al suo collega David Sherman (della rivista Life) l’alloggio di Monaco dove, solo poche settimane prima, avevano vissuto Adolf Hitler ed Eva Braun. Ciò che Lee notò prima di tutto fu l’assoluta mediocrità degli arredi, le chincaglierie dozzinali esposte senza criterio, quel senso di ordinarietà convenzionale che ridimensionava il feroce dittatore ad un borghese provinciale con poco gusto estetico, e proprio per questo ancora più terribile.
Questo concetto fu espresso anni più tardi da Hannah Arendt che, assistendo ai Processi di Norimberga, teorizzò il concetto di “banalità del male. Ella sosteneva che il male non è mai radicale, non possiede né profondità né tanto meno una dimensione demoniaca. Il male nega l’esistenza stessa del pensiero, perché questo “cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici“, e quando “cerca il male, è frustrato perché non trova nulla“.
In quella casa, tuttavia, Lee Miller trovò il modo di regolare i conti con Hitler con un gesto sfrontato e geniale: si immerse nella sua vasca, per lavarsi di dosso tutta la polvere di Dachau, col suo odore di morte e terrore. Lo scatto, realizzato da David Sherman, è ancora oggi il più grande simbolo surrealista della seconda guerra mondiale.

Lee Miller portò per sempre nel cuore le cicatrici della più cruenta guerra dell’ultimo secolo, ferite alle quali non trovò mai una cura. Smise di fotografare, mise da parte i rullini e la sua fedele Rolleiflex e non volle più saperne di scattare. Neanche l’amore con Roland Penrose, e la nascita di un figlio, Anthony, la aiutarono a fare pace con quei fotogrammi di distruzione e atrocità che la memoria aveva impresso nel suo cervello, e che per tutta la vita condizionarono il suo rapporto col presente.
Fonti: Lee Miller’s War, Photographer And Correspondent With the Allies in Europe 1944-45, di Lee Miller a cura di Anthony Penrose; La vasca del Fuhrer, Serena Dandini, Giulio Einaudi Editore, Torino 2020
L’intero archivio fotografico di Lee Miller è a disposizione sul sito internet https://www.leemiller.co.uk/