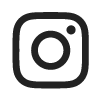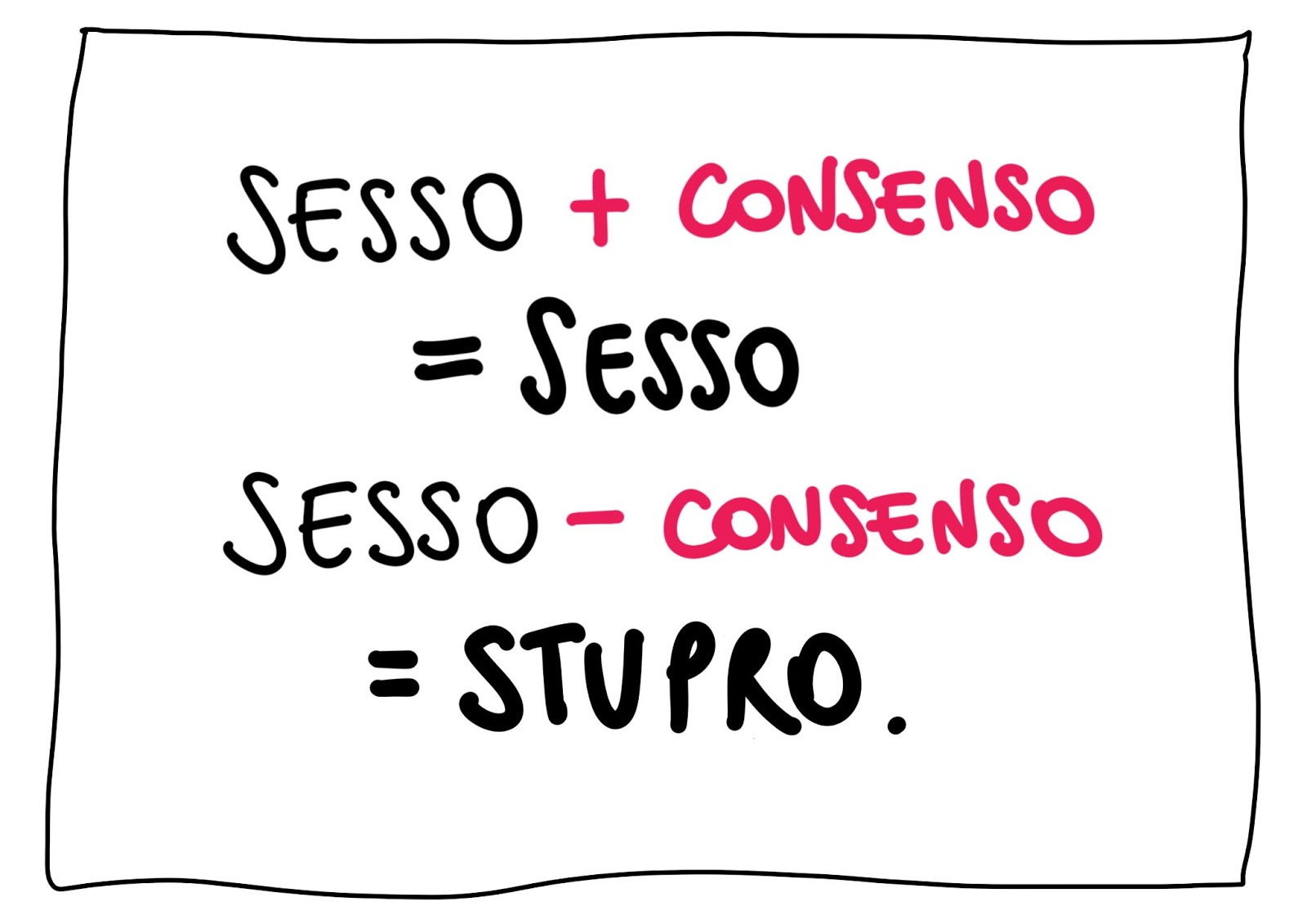Il 12 marzo c’è stata l’Assemblea Nazionale del Partito Democratico che ha ufficialmente eletto come sua Segretaria Elly Schlein, che contro ogni previsione ha vinto con un’alta percentuale le primarie del 26 febbraio.
L’avvenimento può essere considerato storico da un punto di vista politico, in quanto, per la prima volta, il maggior partito del centro sinistra ha come leader una donna, giovane, lontana dai valori tradizionali che invece contraddistingue la sua avversaria, ovvero Giorgia Meloni, premier e leader di Fratelli D’Italia.
Il giorno dopo le primarie, e tutt’ora in alcune occasioni, moltissimi post sui social esprimevano i complimenti al nuovo segretario del partito, in riferimento a Elly Schlein. Post scritti anche da donne, donne progressiste, donne attiviste per la parità di genere, senza far caso che, l’appellare al maschile una donna, compromette la lotta per il raggiungimento di quella parità.
Può davvero una parola aiutare al raggiungimento della parità? Si, anche se l’effetto non è immediato.
L’attivismo linguistico, ovvero la divulgazione del corretto uso nella lingua nei contesti sociali, è parte integrante della lotta del femminismo intersezionale, che vede ogni pratica, come le discriminazioni stesse, allo stesso livello e in maniera del tutto orizzontale, e la lingua quindi non è da meno.
Partiamo da presupposto che la lingua e il linguaggio sono e creano l’identità di una persona. Nel momento in cui tu dai un nome ad una cosa, permetti all* parlanti di descriverla, appellarla, permettendole dunque di inserirla in un contesto e in una discussione, entrando nei fili logici e di pensiero delle persone. Quando poi si crea un nome per intendere una categoria, per lo più vulnerabile, crei lo strumento fondamentale per inserirlo di fatto in un dibattito politico e gli dai vita. Non a caso, se un fenomeno, un concetto, un’identità, non ha un termine specifico per indicarlo, difficilmente viene preso in considerazione in una qualunque discussione. Infatti, avere nel bagaglio linguistico di una qualsiasi lingua le parole adatte a descrivere te, la tua condizione sociale e la tua vita è un privilegio.
Lo stesso vale per la questione del femminile, come declinazione di un termine: nel momento in cui decidi di declinarlo, per indicarne, appunto, il genere, si compie, nel suo piccolo, un atto politico perché, esattamente come nella creazione di nuovi morfemi per visibilizzare quella cosa/persona/fenomeno che vuoi indicare, rendi visibile, in questo caso, il genere più invisibilizzato perché discriminato.
Usare il genere corretto, quindi del femminile per indicare una persona con un’identità di genere femminile, dovrebbe essere una normale conseguenza grammaticale: nel momento stesso in cui avete letto la frase precedente, sembra che io abbia scritto un concetto lapalissiano.

Ma come si è visto nella questione Schlein segretaria, come anche con le varie resistenze nell’utilizzo delle parole assessora, avvocata, ministra e così via, il dibattito è ancora a tratti ferocemente acceso.
Nonostante la grammatica lo imponga, si fa difficoltà ad utilizzare il femminile perché poco abituati a sentirlo, soprattutto per indicare i mestieri con ruoli apicali (e quindi che detengono un qualche potere) o che son sempre stati a trazione maschile (e spesso le due cose coincidono).
Il fatto che alcuni termini femminili sembrino cacofonici è proprio perché poco usati finora in quanto le donne non hanno potuto svolgere tali mestieri, frutto di una cultura patriarcale che ci accompagna dai tempi più antichi. Il solo fatto che non vengano mai utilizzati crea anche un bias che tali mestieri non siano fatti per le donne, disincentivando le donne stesse a percorrere quella strada.
Quindi, il circolo è vizioso: non si usa il femminile professionale perché poco abituati a sentirlo in quanto poche donne svolgono/svolgevano quella professione: per abitudine si usa quindi il maschile. Usando il maschile non si visibilizzano le donne che effettivamente quella professione la svolgono, scoraggiando le donne stesse, inconsciamente, ad intraprendere quella strada lavorativa perché convinte che non siano del “genere giusto”. E così, meno donne svolgeranno quel mestiere, meno femminili professionali ci saranno, e meno donne verranno spronate a intraprendere quella strada considerata a trazione maschile, confermata anche dalla lingua utilizzata per parlarne.
Cosa si può fare?
Iniziamo dunque qui il nostro impegno nell’utilizzare il femminile professionale. Facendolo creiamo dello spazio e puntiamo il riflettore sull’opportunità delle donne nel diventare avvocata, segretaria di partito, ministra, direttrice d’orchestra e così via.
Agevoliamo, insieme a tante altre azioni che possiamo fare, la rottura del tetto di cristallo che consente pian piano alle donne di raggiungere la parità di diritti.
Insieme alla lobby politica, alle manifestazioni in piazza, alle leggi sulla tutela, il lavoro sindacale, una “A” finale può iniziare farci abituare all’idea che una segretaria non è solo una donna che batte a macchina e riceve le telefonate del capo, ma la leader di un partito di sinistra, da sempre condotta da uomini.