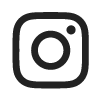Non accenna a placarsi la polemica della vittoria di Mahmood a Sanremo con “Soldi“. Mentre martedì pomeriggio il giovane cantante scioglieva le riserve sulla sua partecipazione all‘Eurovision Song Contest di Tel Aviv, leggevo centinaia di commenti di detrattori che ne delegittimavano la vittoria al Festival perché non benedetta dal voto popolare (ricordiamo che, per pochi punti percentuali, il 50% composto da sala stampa e giuria d’onore ha sovvertito il voto popolare che vedeva come vincitore Ultimo con “I tuoi particolari“)
Ma non solo: contro Mahmood si è scagliata la rabbia di patrioti, salviniani e puristi un-tanto-al-chilo della canzone italiana che hanno visto nel giovane cantante milanese (sì, milanese) l’incarnazione di ogni male finora propagandato: cognome arabo, carnagione olivastra, omosessuale, supportato dalla élite. Ovviamente con i dovuti distinguo.
“Per me non c’entra la nazionalità, è che la canzone è proprio brutta”
Esempio di commento – tipo
Già, la canzone è brutta.
Come se Sanremo ci avesse abituati alla vittoria di brani che sono diventati la nuova Imagine o la nuova Let it be.
Al netto di questo, il brano di Mahmood, “Soldi“, che ha collezionato al televoto finale il 21% (e non il 14% come precedentemente riferito), è talmente brutto che non solo è primo nell’airplay radiofonico aggregato di earone (con un significativo distacco sul secondo, Achille Lauro con “Rolls Royce”), ma sta letteralmente impazzando in ogni classifica di ordine e grado: già fenomeno virale su Spotify con un milione e mezzo di streaming giornalieri (primo in Italia, dove sta macinando ogni record, e in top globale), “Soldi” mantiene saldamente la testa della classifica su Apple Music e Itunes.
Raramente una canzone vincitrice di Sanremo ha mai avuto un seguito simile. Che piaccia o meno, siamo davanti ad un nuovo fenomeno musicale nel panorama italiano.
“Soldi” è un brano autobiografico
Scritto di proprio pugno dallo stesso Mahmood, “Soldi” è la storia del controverso rapporto tra un padre assente e un figlio che è dovuto crescere senza la figura paterna. Un padre che abbandona la famiglia quando Mahmood ha sei anni, e del quale vengono riportate alcune frasi in arabo: “Waladi waladi habibi ta’aleena” (Figlio mio, figlio mio, amore, vieni qua), che segnano un momento preciso nell’infanzia del ragazzo, insieme ai riferimenti al ramadan e al narghilè. Soldi racconta di una crescita personale, cristallizzando in musica, su una base hip hop con venature trap e accenti mediorientali, quel momento in cui anche i figli iniziano ad essere critici nei confronti di figure apparentemente sacre e inviolabili, come i propri genitori. Il finale è eloquente: “Lasci la città ma nessuno lo sa, ieri eri qua, ora dove sei papà?.

Le polemiche
Alimentate da “esperti musicali” del calibro di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, le polemiche contro la vittoria di Mahmood, che non ha colpe all’infuori di possedere un cognome non italiano, non si sono fatte attendere. Una vera e propria caterva di insulti, offese, ingiurie, generate da un ingiustificabile odio verso tutto ciò che rimanda al mondo arabo si è riversata a pioggia sui social. Come se Mahmood fosse un foreign fighter scappato dal C.A.R.A. di Mineo o avesse aderito allo Stato Islamico tra un’intervista a “La vita in diretta” e un collegamento con Michele Guardì.
La ragione non è, ovviamente, solo riferibile al voto popolare disatteso (e anche su questo ci sarebbe molto da dire), ma ad una chiara e precisa tendenza razzista ad assimilare una parte per l’insieme.
Impossibile, per il rozzo accattone del web (che oltretutto vede giustificati i suoi deliri dal profilo fb del suo leader politico preferito), distinguere tra “origine” e “nazionalità”, “genere” e “contaminazione”, “voto popolare” e “televoto”.
Non è forse che, a fronte di una fanbase meno ampia del Volo e di Ultimo, la canzone di Mahmood abbia convinto giurati e giornalisti con una visione musicale più lungimirante rispetto al pubblico più affezionato ai propri beniamini?
Vieni avanti, straniero!
Di concorrenti e vincitori di Sanremo stranieri – o anche di origine straniera – a Sanremo ce ne sono stati diversi. Chi inneggia all’autarchia musicale e teme per la contaminazione della tanto amata musica italiana (amatissima, tanto da avere una rappresentanza discografica nazionale in classifica piuttosto flebile), probabilmente non conosce la storia del Festival.
Solo tre anni fa Carlo Conti ha aperto le porte dell’Ariston, da regolamento, a cantanti non italiani. La prima a beneficiare di questa clausola è stata Lara Fabian, celebre voce di “Adagio”, che in pochi ricorderanno anche a Sanremo con la sua “Voce”, eliminata quasi subito. E che dire di Ermal Meta, che in Italia ci è arrivato dall’Albania già cresciutello negli anni ’90? Tre festival di fila, una carriera lanciata praticamente a Sanremo e una vittoria in coppia con Fabrizio Moro. La sua “Non mi avete fatto niente” ha anche rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest classificandosi quinta. Ricordo diverse polemiche sulla canzone, che riprendeva l’inciso di un altro brano di Andrea Febo, “Silenzio”, non certo, però, sulla nazionalità di Meta
Andiamo ancora indietro: 2008. Nell’ultima edizione targata Baudo a vincere sono Giò di Tonno e Lola Ponce, con “Colpo di fulmine“. Lei è argentina, anche se ormai di nazionalità italiana. E ad essere pignoli nel mezzo ci era passata Raquel del Rosario, spagnola, in duetto con Luca Barbarossa nel 2011. E nel 2009 Pupo e Paolo Belli coinvolgeva in gara Youssun N’Dour, nel 2006 Carlò Fava chiamava con se l’israeliana Noa.
Nel 1999 un’artista nata a Bari da mamma italiana e papà albanese, Anna Oxa, torna a vincere Sanremo dopo aver già trionfato nel 1989. Nel 1991 Riccardo Vincent Cocciante, papà italiano, mamma francese e nato a Saigon (Vietnam), sbaraglia la concorrenza con “Se stiamo insieme“, nel periodo più florido della sua carriera.

E, dulcis in fundo, nel 1983 a Sanremo gareggia la cantante di colore Amii Stewart con un brano interamente in lingua inglese, Working late tonight. Due anni dopo il messicano Luis Miguel arriva secondo con “Noi, ragazzi di oggi“.
Le cronache sanremesi non raccontano di insurrezioni popolari in nessuno di questi casi, probabilmente perché per anni la contaminazione musicale e la nazionalità non hanno mai rappresentato un limite alle proposte festivaliere, o non sono mai state strumentalizzate per propaganda politica.

La questione televoto
Non sono mai stato un fervente sostenitore del televoto, né un accanito televotante. Il limite dello strumento è, da sempre, quello di rappresentare non già una porzione fedele di pubblico quanto un riflesso del numero di fans disposti a pagare una certa somma per accordare una preferenza. Oppure di accordare logiche di empatia che poco hanno a che fare con il valore musicale, discografico o radiofonico di una canzone.
Il televoto non è mai stato uno strumento democratico, perché se così fosse, sarebbe accessibile a tutti gratuitamente.
Già negli anni ’80, una rudimentale forma di televoto (le schiedine Totip) condusse alla vittoria artisti dal grande seguito popolare: Ricchi e Poveri, Albano e Romina (solo per citarne alcuni). Pupo, diverse volte in gara tra il 1980 e il 1984, ha più volte ammesso di aver acquistato vagonate di schedine totip per autovotarsi. A fare le spese di questo sistema, una vittima eccellente: Mia Martini con “Almeno tu nell’universo” (solo nona nel 1989), superata, quell’anno, perfino da Francesco Salvi e da un emergente Jovanotti.
Per anni, Sanremo si è affidato al voto congiunto di giurie di qualità e demoscopiche per eleggere la canzone vincitrice. Un meccanismo non certo perfetto, se si pensa alle ingerenze baudiane per la vittoria di Ron e Tosca nel 1996 ai danni di Elio e le Storie Tese (una storia mai chiarita del tutto, che scardinò l’impero Sanremese costruito da Pippo Baudo, il quale tornò al Festival solo sei anni dopo), ma rappresentativo di un parere tecnico e uno popolare del tutto disinteressato.
Dopo l’introduzione del televoto, la prima edizione ad affidarsi totalmente all’attività telefonica degli spettatori fu quella del 2004. Annus horribilis per quanto riguarda le canzoni in gara (le case discografiche disertarono e nel girone unico della gara si ritrovarono nomi come Danny Losito, Stefano Picchi e Linda Valori). A spuntarla, per assenza di contendenti fu uno dei più famosi cantanti nel lotto: Marco Masini con “L’uomo volante”.

Con un rapido balzo voliamo al 2006, altra edizione piuttosto discutibile. Il vincitore della categoria uomini è Povia, con quella che è passata alla storia come “la canzone del piccione“, ossia “Vorrei avere il becco“. Copie vendute? Meno che niente, ma tanto affetto nel televoto che lo condusse vincitore assoluto e tanta empatia verso colui che, fuori gara, l’anno precedente aveva incantato grandi e piccoli con “I bambini fanno oh“.
Stessa sorte nel 2009 per Marco Carta, che grazie ai suoi fans “cartini” vince un festival brutto e sgraziato, davanti all’indecente “Luca era gay” di Povia e a Sal da Vinci. Un disastro per le vendite degli album, mai così basse, e un requiem per la musica italiana.
Il copione si ripete nel 2010, quando il televoto elimina canzoni davvero meritevoli come “Ricomincio da qui” di Malika Ayane e “Per tutta la vita di Noemi”, a favore dell’incomprensibile e provocatoria “Italia amore mio” con Pupo ed Emanuele Filiberto e soprattutto di “Per tutte le volte che” di Valerio Scanu, reduce da Amici di Maria De Filippi, che vince nell’incredulità generale.
Canzoni ricordate come esempi negativi di ciò a cui Sanremo può portare: psicosi collettive che si riversano nel televoto incontrollato come strumento di sfogo, che nulla ha a che vedere con la meritocrazia musicale.

Quale sarebbe la formula giusta?
La storia recente di Sanremo ha insegnato che il solo televoto non è sempre la migliore delle soluzioni per eleggere il vincitore: serve un correttivo.
Perché non ispirarsi ai Festival europei? Già da molti anni, nelle kermesse musicali del nord Europa come il Melodifestivalen svedese (ispirato, nella struttura, all’Eurovision Song Contest) si riscontra un buon mix di giurie partecipare al 50% alla decretazione del vincitore finale. Nel caso del Melodifestival si fa affidamento a una serie di giurie estere, provenienti da tutto il continente (il Melodifestivalen, a differenza di Sanremo, è un programma costruito ad hoc come selezione naturale per l’Eurovision), così da rendere la canzone vincitrice accattivante al gusto internazionale.
All’Eurovision, invece, al televoto si accosta una giuria nazionale composta da professionisti del mondo della musica.
La considerazione nasce spontanea: il sistema di voto sanremese vigente è assolutamente perfettibile. Perché non abolire il fardello della sala stampa (che già assegna il Premio della Critica) e allargare la giuria d’onore ad accademici, musicologi, musicisti e addetti ai lavori, a tutti i livelli, del mondo della musica?
In tal modo, con una giuria tecnica ampia e legittimata e il voto popolare, andrebbe ad incontrarsi il favore del pubblico e quello dei professionisti, che non rappresenterebbero più un’élite selezionata ma una giuria qualificata, come avviene nei Festival di arti diverse come il cinema, la letteratura o la fotografia. Sarebbe la formula più giusta per mettere a tacere ogni tipo di critica.