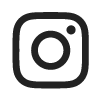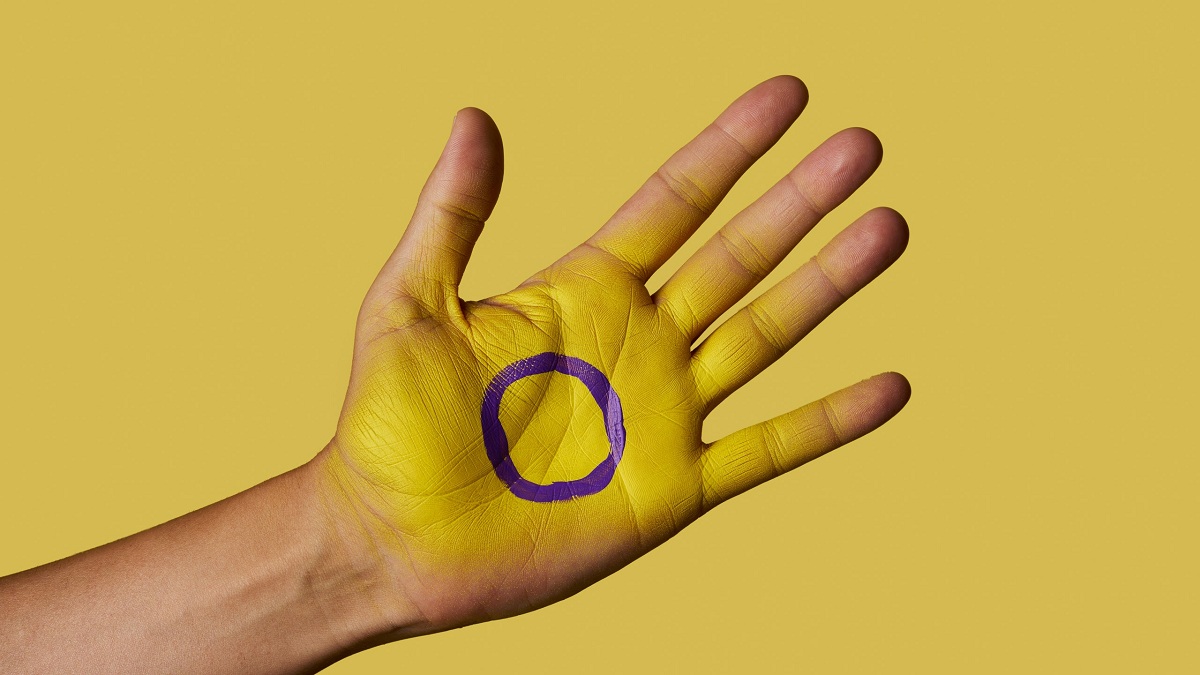Si è parlato molto delle persecuzioni delle persone omosessuali in Italia e in Europa durante la seconda guerra mondiale, un po’ meno invece delle persone transgender, che hanno subìto le leggi razziali tanto quanto le altre categorie colpite.
In Italia in particolar modo si hanno davvero pochissime testimonianze: forse l’unica è proprio quella di Lucy Salani, 97enne transgender, che ha sofferto in prima persona persona la violenza dell’epoca.
Lucy è nata a Fossano nel 1924 in una famiglia antifascista di origini emiliane e come detto da lei stessa all’Arcigay in occasione della Giornata della Memoria 2021, “si è sempre sentita femmina sin da piccola“, nascondendo per anni le sue relazioni omosessuali sia per la sua famiglia sia per paura delle ritorsioni fasciste dell’epoca.
“Mia madre era disperata. Volevo sempre fare ciò che a quell’età facevano le bambine: cucinare, pulire e giocare con le bambole. Mio padre e i miei fratelli non mi accettarono. Negli anni trenta i miei genitori si trasferirono nel bolognese e fu così che in città allacciai amicizie con diversi omosessuali. Allora non si parlava di omosessualità, non si doveva dare troppo nell’occhio, le bande di fascisti dove trovavano persone come noi combinavano sempre guai, picchiavano, rapavano, imbrattavano di catrame“.
Fu Bologna quindi la città dove iniziò a sentirsi al suo posto, con la sua comunità, finché non arrivò il momento in cui dovette arruolarsi, come tutti gli italiani di allora.
L’esercito e il campo di concentramento
Costretta ad arruolarsi più avanti, si dichiara omosessuale ma non viene creduta: “si, si… dicono tutti così, vai!“, le risposero.
Ma dopo l’armistizio del 1943, diserta e prova a tornare dalla sua famiglia. Dopo poche settimane nascosta in campagna, viene trovata dai nazisti: “Io mi nascondevo con un altro ragazzo, ma non lo conoscevo. Ci hanno fermati e messi in galera e ci hanno interrogati. Per ogni risposta che loro consideravano errata, noi ricevevamo botte! Quel poveraccio l’hanno preso a mazzate.“
Si unì così all’esercito, questa volta nazista, ma poco dopo disertò di nuovo, fingendo una bronchite. Ed è proprio perché disertrice, e non transgender, che la catturarono e la condannarono a morte, spedendola nei campi di concentramento a Dachau, dove vide la morte in faccia: persone che si attaccavano per un pezzo di pane in più, persone che morirono suicida, persone legate con catene.
“Quello che ho visto nel campo è stato spaventoso, l’Inferno di Dante a confronto è una passeggiata: impiccati, gente che moriva per la strada, persone che erano solo pelle e ossa. Facevano gli esperimenti: bruciavano i morti e c’era chi era ancora vivo, che si muoveva fra le fiamme. La mattina quando ti alzavi e guardavi la recinzione elettrificata, trovavi un mucchio di ragazzi attaccati: avevano provato a scappare durante la notte“
“L’orrore, la disperazione, la fame, l’annientamento, l’umiliazione, la detenzione, il disgusto. Speravo tanto che ci bombardassero, per mettere fine a tutto questo” prosegue, senza risparmiare dettagli forti: “Appena arrivati ci hanno denudati, pelati e disinfettati, dicevano loro. Disinfettati con la creolina. Un bruciore bestiale! La pelle se ne veniva via il giorno dopo. Se avevi un po’ di carne addosso vivevi, altrimenti partivi già condannato. Non avevamo più un nome, ma solo un numero. Nel campo lavoravo, portavo i cadaveri ai forni. Ci ho passato sei mesi”.
A pochi giorni della liberazione, e dopo 6 mesi della sua cattura, i tedeschi iniziano a sparare in massa verso i prigionieri. Lei fu ferita ad una gamba e ritrovata tra i cadaveri dagli americani, che la riportarono in Italia.

La vita di Lucy Salani dopo il campo di concentramento
Tornata a casa Lucy si trasferì a Torino. Inizia, così, la sua seconda vita girando l’Italia con alcune compagnie teatrali e circensi, vive facendo piccoli sketch comici da travestito e la ballerina di rivista. Ebbe numerosi amanti e fidanzati e spesso, nei momenti più difficili, continuò a prostituirsi. Più avanti iniziò a lavorare come tappezziera per tutto il Nord Italia. Iniziò a condurre una vita piena, con amici, relazioni, con serenità. Conobbe Patrizia, un’adolescente orfana, che andò a vivere con lei ed iniziò a diventare come sua figlia adottiva. Da li a poco, Patrizia iniziò a chiamarla “Mamma”, perché era quello che era: una madre.
Nel 1982, va a Londra per sottoporsi a un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso: è una delle prime italiane a farlo anche se, più che un operazione parliamo di una vera e propria macellazione: “Hanno fatto i macellai: tagliato e fatto un buco” dice crudo Matteo Botrugno, uno dei due registi del film su di lei “C’è un soffio di vita soltanto“, insieme a Daniele Coluccini.
Decide comunque di mantener il suo nome originario (“Perché una donna non può chiamarsi Luciano?” dice lei) creando non pochi problemi ancora oggi: nel 2018 le è stato rifiutato l’accesso a una casa di riposo.
Oggi vive a Bologna nella periferia di Borgo Panigale, assistita da volontari che sono ormai la sua famiglia, insieme a Said, un quarantenne marocchino, che è ormai suo nipote, diventando quindi da madre a nonna.
Vive in maniera serena con i suoi amici, e la sua storia verrà per sempre raccontata nel film “C’è un soffio di vita soltanto”, perché la sua storia e la sua voce non può esaurirsi in così poco tempo.
Anche se le sono tornati i dolori alla gamba: “Mi sono tornati dei problemi alla gamba alla quale mi hanno sparato durante la liberazione del lager di Dachau. Se guido mi fa molto male”.
Perché alla fine succede sempre così: ci si prova ad andare avanti, a superare gli orrori di quell’epoca disastrosa e catastrofica, che ha messo fine a migliaia di vite, ma c’è sempre qualcosa che ce lo ricorda e non si scappa, non si può dimenticare.
Anzi, non si deve dimenticare, proprio perché fa male. Proprio perché bisogna e si deve imparare. E’ una lezione che ha portato via troppe persone innocenti per non essere appresa.
E anche se non si vorrebbe, il passato torna sempre.
Leggi anche: Josef Kohout, la storia dell’uomo dal triangolo rosa