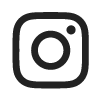PARASITE, premiato all’ultimo Festival di Cannes, è un film dannatamente sublime che guarda con crudele sarcasmo alla società moderna e al divario incolmabile tra sogno di ricchezza e povertà.
Corea del Sud.
La famiglia Ki-taek vive alla giornata in un quartiere malfamato.
La loro casa è un seminterrato e la finestra della sala da pranzo si affaccia su di una stradina dove puntualmente un ubriaco va a pisciare. Vivono di stenti e di lavoretti sottopagati, ma sembrano felici.
Poi un giorno il loro figlio maschio riceve un’offerta di lavoro presso una ricca famiglia borghese, i Park.
Non passerà molto tempo che tutta la famiglia Ki-taek riuscirà a inserirsi in quella casa sotto mentite spoglie…
Bong Joon-ho dirige un film compatto e perfetto sotto ogni punto di vista e in esso albergano diverse anime che però si fondono in maniera altrettanto perfetta, quasi necessaria.

PARASITE guarda con cinismo alla condizione in cui vessa una grande fetta della popolazione sud coreana, ma per quanto si trattino temi drammatici come la povertà o la disoccupazione, i toni non sono quasi mai seri. Si ride e si ride tanto, talvolta a denti stretti, fino a che non ci si ritrova attanagliati dalla tensione e il film non diventa un vero e proprio thriller fino allo sconcertante finale.
Già in passato il regista aveva affrontato il tema della lotta delle classi sociali costruendo uno dei più interessanti film di azione del 2013, “SNOWPIERCER” . Tratto da una serie di fumetti francesi il film raccontava di una nuova era glaciale che aveva decimato la popolazione sulla terra e dei sopravvissuti che viaggiavano su di un treno verso la speranza di una nuova civiltà. Il treno però era un microcosmo di società diviso in classi sociali: i più poveri stavano negli ultimi vagoni e lavoravano costantemente affinché non venisse mai a mancare l’energia sul treno, mentre i ricchi stavano nei vagoni anteriori sfruttando i più sfortunati. Presto però scoppia un’insurrezione.
Se in “SNOWPIERCER” la tensione e l’azione sono in un certo senso “orizzontali” in cui la scalata del successo avanza vagone dopo vagone, in PARASITE questa è verticale.
La famiglia Ki-taek vive nella zona più bassa del paese e la loro casa è un seminterrato, mentre la splendida dimora dei Park si erge nella parte alta della città ed è costruita su più livelli.
E all’interno della stessa villa dei Park questo divario sociale si farà più evidente: i piani superiori sono destinati alle camere da letto cui l’accesso ai Ki-taek è limitato, il piano terra è la zona comune che si affaccia su di uno splendido giardino, un piccolo angolo di paradiso e poi vi è lo scantinato da cui prenderà via l’imprevedibile lotta alla sopravvivenza e la rivolta.

In tal senso PARASITE ha non pochi punti in comune con un’altra recente pellicola vista sul grande schermo, “NOI” di Jordan Peele.
Ma se nell’horror di Peele ci viene mostrato come l’unione dei reietti, nascosti e relegati nel sottosuolo, possa portare avanti una rivolta affinché le genti più povere arrivino ad abbracciare e impossessarsi del sogno americano; in PARASITE questa unione tra poveri non avviene (la famiglia Ki-taek di fatto ruba il lavoro a quelli che stavano prima di loro) e sarà sempre più evidente come la loro ascesa sarà costellata di difficoltà insormontabili.
Per quanto il film possa sfociare o avanzare per situazioni al limite del paradossale, lo sguardo del regista e la sua chiusura sono crudelmente sinceri e reali. Non vi è redenzione e non vi è alcuna speranza poiché siamo quello che siamo – pare suggerirci Bong Joon-ho – e le maschere che tentiamo di portare, presentandoci e vendendoci per altro da ciò che realmente siamo, queste finiscono per cadere e tutti siamo destinati a perdere qualcosa. Ma a pagarne lo scotto maggiore sono e saranno sempre i più poveri che per quanto possano tentare di essere accolti e ascoltati dai ricchi, non saranno mai accettati (l’odore che la famiglia Ki-taek emana infastidisce la famiglia Park) e saranno trattati sempre come servi.

Questa emergenza è ben evidenziata in diverse scene come quella in cui si apre il film dove i figli dei Ki-taek sono impegnati a ricercare una connessione wi-fi gratuita che troveranno soltanto piegati, su di un ripiano dove troneggia il gabinetto, nell’angusto bagno. Ma ancora più evidente sarà quando – come un giudizio universale – il paese sarà colpito da un’alluvione. Se questa porterà i Park a dover rinunciare a una vacanza e al sogno di portare i figli in campeggio, per la famiglia Ki-taek la pioggia porterà via loro tutto ciò che possiedono (la loro abitazione sarà completamente sommersa dalle acque putride) e saranno costretti a dormire ammassati con i sopravvissuti in una grande palestra del quartiere.
PARASITE non presenta sbavature: ogni inquadratura, ogni movimento della cinepresa, ogni dialogo, l’uso della luce e degli spazi e dei colori, la colonna sonora, gli attori; sono tutti elementi essenziali perché si costruisca un sogno che diventa un incubo a occhi aperti dove non esistono buoni e cattivi, ma solo anime alla deriva o sguardi ciechi sull’altro, dove i ruoli sociali sono definiti nella loro tragicità o indifferenza (emblematica è la scena che vede i Park trastullarsi sul divano, a far i loro “porci comodi”, ignari e ciechi di chi sta letteralmente sotto di loro, per terra, tra gli avanzi della cena).
E se la chiusura di PARASITE è quanto di più amaro potessimo sopportare è però il solo finale possibile. Improvvisamente da che si rideva o si restava pietrificati davanti a quanto accaduto fino a pochi minuti prima, ci si alza dalla poltrona con un senso di sconfitta e un magone alla gola.
Perché certi sogni sono più grandi di noi e non sono alla portata di tutti.
[rwp-review id=”0″]